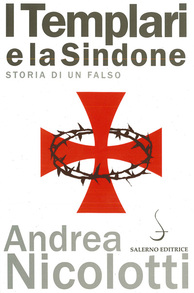I Templari e la Sindone. Storia di un falso
di Andrea Nicolotti, Casa editrice Salerno (Collana Aculei), Roma 2011. 188 pp.
Recensione di Gaetano Ciccone ([email protected])
È uscito in questi giorni un nuovo libro sulla Sindone di Torino. La bibliografia sull’argomento era già
sterminata: c’era proprio bisogno di un nuovo libro? Sì! Senza dubbio. L’Autore, Andrea Nicolotti, ha al
suo attivo alcuni volumi e numerosi articoli sulla storia e la letteratura del cristianesimo antico. Si è
dedicato anche allo studio delle più recenti ‘scoperte’ storiche riguardanti la Sindone: le pretese scritte
viste su di essa. e i manoscritti medievali citati per avvalorare l’ipotesi di un ‘periodo templare’ della stessa
Sindone.
Perciò molto atteso era il suo volume in cui elenca e valuta le ipotesi proposte dai vari autori per spiegare
il presunto passaggio della Sindone da Costantinopoli a Lirey in Francia tra il 1204 e il 1355. Nicolotti ricorda
che in realtà non esiste alcuna traccia o indizio per collocare la Sindone (detta poi di Torino) in Costantinopoli
in data anteriore alla quarta crociata (1204). Oltremodo scorretto, dal punto di vista storico, è l’attribuire alla
Sindone di Torino qualsiasi riferimento a una qualche sindone anteriore all’anno 1204, dato che è ben noto
che le sindoni esistenti allora e in seguito sono state molteplici. Ridicolo anche pensare che il Mandylion di
Edessa, un piccolo fazzoletto col volto di Gesù vivente, fosse la Sindone di Torino sotto mentite spoglie, di
cui nessuno conosceva la vera essenza, ma che i pittori, misteriosamente, potevano riprodurre anche nei
minimi particolari. Senza contare che il destino del Mandylion di Edessa è noto, essendo andato a finire
nella Sainte Chapelle di Parigi, dove è rimasto fino alla Rivoluzione francese.
In particolare il racconto di Robert de Clari in merito alla esposizione settimanale, tutti i venerdì, di una
‘sydoines’ con l’immagine di Cristo nella chiesa delle Blacherne di Costantinopoli, non può essere riferito
alla Sindone di Torino, dato che non si precisa se l’immagine era del solo volto o di tutto il corpo, né se era
dipinta o ricamata e neanche se l’immagine era sul telo o dietro il telo. La spiegazione più semplice, secondo
il Nicolotti, è la seguente: il cronista francese ha confuso il miracolo abituale del venerdì alle Blacherne,
relativo a un quadro della Madonna col bambino, con un racconto relativo alla sindone. Se non si accetta la
spiegazione del Nicolotti, ci ritroviamo a dover pensare a due miracoli abituali del venerdì nella chiesa delle
Blacherne, quello relativo al ritratto della Madonna e quello della sindone, al quale ultimo però non accenna
nessun altro autore.
Altro punto qualificante del libro è la dimostrazione della falsità di un presunto documento, che collocherebbe
la sindone in Atene nel 1205. Non si tratta infatti, e non si può trattare secondo quanto spiegato, con
motivazioni storiche e diplomatiche, della trascrizione e traduzione di un documento originale del XIII secolo.
Nicolotti arriva anche a ipotizzare chi, quando e perché nel XIX secolo avrebbe prodotto tale falsificazione.
La parte centrale del libro tratta dell’ipotesi, prospettata per primo da Ian Wilson nel 1978, che la Sindone sia
stata ‘rubata’ durante il saccheggio di Costantinopoli del 1204 e ceduta ai Templari, i quali l’avrebbero
considerata il loro emblema e fatta oggetto di una venerazione speciale, il tutto però nel più assoluto segreto.
Di tale segretezza non si capisce assolutamente il senso, dal punto di vista storico, dato che l’appropriarsi di
beni del nemico durante un saccheggio era considerato un fatto più che legale e venerare una reliquia era
azione commendevole. Chi dei crociati durante il saccheggio o nella divisione del bottino entrò in possesso di
qualche reliquia se ne fece gran vanto e la riportò in patria in pompa magna. La necessità del segreto, invocata
solo per la Sindone di Torino, in realtà serve soltanto a spiegare la mancanza di notizie sulla presenza della
reliquia a Costantinopoli e sul suo passaggio in Francia. Ecco che l’assenza di fonti storiche relativa a un
preteso fatto storico diventa la principale prova della realtà di tale fatto, sovvertendo così la logica, il buon
senso e l’onere della prova, che spetta a chiunque prospetti una nuova teoria.
Nicolotti poi riprende tutte le sue valutazioni, già espresse in alcuni articoli, in merito alla presunta scoperta
fatta da Barbara Frale di un documento in cui un cavaliere templare avrebbe fatto un preciso riferimento alla
Sindone di Torino: una frase pronunciata durante un interrogatorio nel processo finale dei Templari
dimostrerebbe che il supposto idolo dei Templari era una immagine su tela e non una testa tridimensionale.
L’Autore si sofferma su questo unico punto di un libro della Frale [1], non perché questo sia l’unica falsa
interpretazione presente nel libro. Infatti gli errori e i sentiti dire riportati male abbondano in esso. Nicolotti
analizza con particolare attenzione questa affermazione perché essa costituisce l’unico spunto originale
nel libro della Frale, essendo tutti gli altri punti già presenti in vari libri della vulgata sindonica. Egli dimostra,
senza ombra di dubbio, che la lettura di quella frase sul manoscritto del processo templare, come riportata
dalla Frale, è erronea e la sua traduzione è arbitraria e profondamente sbagliata. Peggio ha fatto la Frale
quando, in alcuni articoli di risposta alle critiche, ha cercato di modificare la sua lettura e di giustificare la
sua interpretazione.
Il fatto che ad accorgersi per primi dell’errore della Frale siano state alcune persone estranee al mondo accademico,
che la Frale definisce sprezzantemente ‘blogger’, non toglie nulla alla gravità del suo errore,
anzi l’acuisce. Tantomeno la Frale può portare a sua giustificazione, come sembra fare, il fatto che tale errore
sia stato scoperto immediatamente dopo l’uscita del suo libro. Nulla le serve ventilare l’esistenza di chissà
quali complotti contro di lei [2]. Anche la polemica che è seguita alla pubblicazione dei primi articoli sull’errore
della Frale, è riportata per sommi capi nel volume di Nicolotti.
Nicolotti, in ultima analisi, difende il metodo storico e l’uso del buon senso contro le mistificazioni di una
storiografia che puo tranquillamente essere definita ‘pseudostoria’.
1 Barbara Frale, I Templari e la sindone di Cristo, il Mulino [Intersezioni 346], Bologna 2009.
2 Barbara Frale, La crociata del “signum fusteum”. Note su alcune critiche al libro I Templari e la sindone di Cristo, Giornale di Storia, 3 (2010), In due passaggi di questo articolo l’Autrice si lamenta della velocità con cui i cosiddetti ‘blogger’ hanno svelato il suo errore: dapprima a pagina 2 e poi riprende l’argomento a pagina 14 (“Da ultimo, vorrei richiamare l’attenzione di chi legge sulla cronologia delle vicende legate alle critiche ai mieri lavori. Poche settimane dopo l’uscita del libro … compaiono su un blog amatoriale delle critiche alla mia tesi …”) L’Autrice però non completa il discorso sul significato che ha per lei tale rapidità, lasciando supporre chissà quali retroscena. La spiegazione più ovvia però è la seguente e non è favorevole alla Frale: l’errore è talmente evidente che chiunque con un po’ di attenzione poteva accorgersene.
di Andrea Nicolotti, Casa editrice Salerno (Collana Aculei), Roma 2011. 188 pp.
Recensione di Gaetano Ciccone ([email protected])
È uscito in questi giorni un nuovo libro sulla Sindone di Torino. La bibliografia sull’argomento era già
sterminata: c’era proprio bisogno di un nuovo libro? Sì! Senza dubbio. L’Autore, Andrea Nicolotti, ha al
suo attivo alcuni volumi e numerosi articoli sulla storia e la letteratura del cristianesimo antico. Si è
dedicato anche allo studio delle più recenti ‘scoperte’ storiche riguardanti la Sindone: le pretese scritte
viste su di essa. e i manoscritti medievali citati per avvalorare l’ipotesi di un ‘periodo templare’ della stessa
Sindone.
Perciò molto atteso era il suo volume in cui elenca e valuta le ipotesi proposte dai vari autori per spiegare
il presunto passaggio della Sindone da Costantinopoli a Lirey in Francia tra il 1204 e il 1355. Nicolotti ricorda
che in realtà non esiste alcuna traccia o indizio per collocare la Sindone (detta poi di Torino) in Costantinopoli
in data anteriore alla quarta crociata (1204). Oltremodo scorretto, dal punto di vista storico, è l’attribuire alla
Sindone di Torino qualsiasi riferimento a una qualche sindone anteriore all’anno 1204, dato che è ben noto
che le sindoni esistenti allora e in seguito sono state molteplici. Ridicolo anche pensare che il Mandylion di
Edessa, un piccolo fazzoletto col volto di Gesù vivente, fosse la Sindone di Torino sotto mentite spoglie, di
cui nessuno conosceva la vera essenza, ma che i pittori, misteriosamente, potevano riprodurre anche nei
minimi particolari. Senza contare che il destino del Mandylion di Edessa è noto, essendo andato a finire
nella Sainte Chapelle di Parigi, dove è rimasto fino alla Rivoluzione francese.
In particolare il racconto di Robert de Clari in merito alla esposizione settimanale, tutti i venerdì, di una
‘sydoines’ con l’immagine di Cristo nella chiesa delle Blacherne di Costantinopoli, non può essere riferito
alla Sindone di Torino, dato che non si precisa se l’immagine era del solo volto o di tutto il corpo, né se era
dipinta o ricamata e neanche se l’immagine era sul telo o dietro il telo. La spiegazione più semplice, secondo
il Nicolotti, è la seguente: il cronista francese ha confuso il miracolo abituale del venerdì alle Blacherne,
relativo a un quadro della Madonna col bambino, con un racconto relativo alla sindone. Se non si accetta la
spiegazione del Nicolotti, ci ritroviamo a dover pensare a due miracoli abituali del venerdì nella chiesa delle
Blacherne, quello relativo al ritratto della Madonna e quello della sindone, al quale ultimo però non accenna
nessun altro autore.
Altro punto qualificante del libro è la dimostrazione della falsità di un presunto documento, che collocherebbe
la sindone in Atene nel 1205. Non si tratta infatti, e non si può trattare secondo quanto spiegato, con
motivazioni storiche e diplomatiche, della trascrizione e traduzione di un documento originale del XIII secolo.
Nicolotti arriva anche a ipotizzare chi, quando e perché nel XIX secolo avrebbe prodotto tale falsificazione.
La parte centrale del libro tratta dell’ipotesi, prospettata per primo da Ian Wilson nel 1978, che la Sindone sia
stata ‘rubata’ durante il saccheggio di Costantinopoli del 1204 e ceduta ai Templari, i quali l’avrebbero
considerata il loro emblema e fatta oggetto di una venerazione speciale, il tutto però nel più assoluto segreto.
Di tale segretezza non si capisce assolutamente il senso, dal punto di vista storico, dato che l’appropriarsi di
beni del nemico durante un saccheggio era considerato un fatto più che legale e venerare una reliquia era
azione commendevole. Chi dei crociati durante il saccheggio o nella divisione del bottino entrò in possesso di
qualche reliquia se ne fece gran vanto e la riportò in patria in pompa magna. La necessità del segreto, invocata
solo per la Sindone di Torino, in realtà serve soltanto a spiegare la mancanza di notizie sulla presenza della
reliquia a Costantinopoli e sul suo passaggio in Francia. Ecco che l’assenza di fonti storiche relativa a un
preteso fatto storico diventa la principale prova della realtà di tale fatto, sovvertendo così la logica, il buon
senso e l’onere della prova, che spetta a chiunque prospetti una nuova teoria.
Nicolotti poi riprende tutte le sue valutazioni, già espresse in alcuni articoli, in merito alla presunta scoperta
fatta da Barbara Frale di un documento in cui un cavaliere templare avrebbe fatto un preciso riferimento alla
Sindone di Torino: una frase pronunciata durante un interrogatorio nel processo finale dei Templari
dimostrerebbe che il supposto idolo dei Templari era una immagine su tela e non una testa tridimensionale.
L’Autore si sofferma su questo unico punto di un libro della Frale [1], non perché questo sia l’unica falsa
interpretazione presente nel libro. Infatti gli errori e i sentiti dire riportati male abbondano in esso. Nicolotti
analizza con particolare attenzione questa affermazione perché essa costituisce l’unico spunto originale
nel libro della Frale, essendo tutti gli altri punti già presenti in vari libri della vulgata sindonica. Egli dimostra,
senza ombra di dubbio, che la lettura di quella frase sul manoscritto del processo templare, come riportata
dalla Frale, è erronea e la sua traduzione è arbitraria e profondamente sbagliata. Peggio ha fatto la Frale
quando, in alcuni articoli di risposta alle critiche, ha cercato di modificare la sua lettura e di giustificare la
sua interpretazione.
Il fatto che ad accorgersi per primi dell’errore della Frale siano state alcune persone estranee al mondo accademico,
che la Frale definisce sprezzantemente ‘blogger’, non toglie nulla alla gravità del suo errore,
anzi l’acuisce. Tantomeno la Frale può portare a sua giustificazione, come sembra fare, il fatto che tale errore
sia stato scoperto immediatamente dopo l’uscita del suo libro. Nulla le serve ventilare l’esistenza di chissà
quali complotti contro di lei [2]. Anche la polemica che è seguita alla pubblicazione dei primi articoli sull’errore
della Frale, è riportata per sommi capi nel volume di Nicolotti.
Nicolotti, in ultima analisi, difende il metodo storico e l’uso del buon senso contro le mistificazioni di una
storiografia che puo tranquillamente essere definita ‘pseudostoria’.
1 Barbara Frale, I Templari e la sindone di Cristo, il Mulino [Intersezioni 346], Bologna 2009.
2 Barbara Frale, La crociata del “signum fusteum”. Note su alcune critiche al libro I Templari e la sindone di Cristo, Giornale di Storia, 3 (2010), In due passaggi di questo articolo l’Autrice si lamenta della velocità con cui i cosiddetti ‘blogger’ hanno svelato il suo errore: dapprima a pagina 2 e poi riprende l’argomento a pagina 14 (“Da ultimo, vorrei richiamare l’attenzione di chi legge sulla cronologia delle vicende legate alle critiche ai mieri lavori. Poche settimane dopo l’uscita del libro … compaiono su un blog amatoriale delle critiche alla mia tesi …”) L’Autrice però non completa il discorso sul significato che ha per lei tale rapidità, lasciando supporre chissà quali retroscena. La spiegazione più ovvia però è la seguente e non è favorevole alla Frale: l’errore è talmente evidente che chiunque con un po’ di attenzione poteva accorgersene.